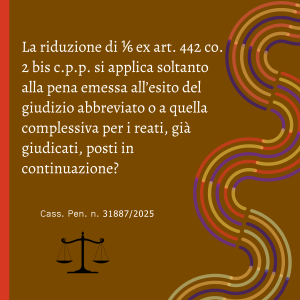La vicenda scelta per la rubrica Dialoghi Penali esplora la configurabilità del reato di appropriazione indebita nel contesto di un giudizio di divisione ereditaria connotato da un’accesa conflittualità tra i due eredi.
Il caso:
Un giorno Tizio scopre che la germana Caia aveva venduto un quadro oggetto del giudizio di divisione, riconoscendo il bene su un sito di un antiquariato.
Immediatamente presenta una denuncia/querela nei confronti di Caia contestando il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. , in quanto quest’ultima aveva la disponibilità esclusiva del bene collocato all’interno dell’abitazione familiare, anch’essa oggetto del giudizio di divisione ereditaria, ove aveva continuato ad abitare.
A seguito di attività investigative, viene appurato che Caia aveva dichiarato all’acquirente, nell’atto di cessione, di essere la proprietaria esclusiva del quadro.
Dalla vendita aveva incassato la somma di € 400,00.
Il PM, valorizzando il valore contenuto del bene compravenduto e l’assenza di precedenti penali a carico dell’indagata, formula una richiesta di archiviazione per tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.
Caia, mia assistita, ha deciso di proporre opposizione alla richiesta suddetta.
Nello specifico, Tizio aveva omesso di riferire nell’atto di denuncia/querela che in data antecedente alla vendita si era appropriato della somma di € 3.000,00, presente su un conto cointestato con la germana.

Nell specifico, aveva chiesto all’Istituto di Credito ove era stato acceso il conto cointestato di emettere un assegno circolare in suo favore pari all’importo presente sul conto corrente di oltre € 6.000,00 e, quindi sottraendo illegittimamente alla sorella anche la quota di sua spettanza.
In ragione di tale comportamento, Caia aveva ottenuto un 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗶𝗻𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗶𝘃𝗼 per l’importo di € 3.000,00 dichiarato esecutivo, in quanto non opposto nel termine di legge.
La difesa:
Nell’atto di opposizione venivano proposti due motivi di archiviazione:
- La causa di non punibilità dello 𝗶𝘂𝘀 𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀 che presuppone un credito certo, liquido ed esigibile;
- La carenza dell’𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 del reato , in ragione sia del credito formatosi in data antecedente rispetto alla vendita, sia dell’importo dell’appropriazione pari ad € 200,00 di gran lunga inferiore rispetto a quello presente sul conto corrente di € 3.000,00, sottratto alla germana.
La decisione:
Il G.I.P. ha accolto l’opposizione spiegata, emettendo ordinanza di archiviazione.
Il giudice ha evidenziato che dalla ricostruzione della vicenda non emerge la prova che la condotta posta in essere fosse sorretta dal fine di conseguire un ingiusto profitto.