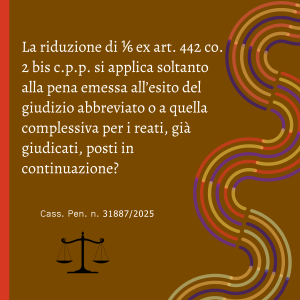Un avvocato penalista a Salerno…
Mi chiamo Fabio Torluccio, sono un avvocato, mio padre desiderava che lo fossi, ma quando, dopo la maturità, mi sono trovato a scegliere se iscrivermi alla facoltà di giurisprudenza più di un dubbio mi ha assalito.
I cinque anni trascorsi sui libri e la lunga gavetta post-universitaria hanno forgiato il mio carattere.
Pian piano, giorno dopo giorno, ho compreso che l’esercizio della professione non è un lavoro, è una missione.
Porti con te ogni giorno i problemi dei clienti, i dubbi sull’esito di un processo e, soprattutto, accetti i tempi di una giustizia lenta, troppo lenta.
Se i problemi sono tanti, è anche vero che quando vinci e, nel mio caso specifico, quando ottieni un’assoluzione, senti che giustizia è stata fatta.
Sono un avvocato penalista a Salerno, un penalista semplificando, uno che non dorme la notte, che studia sempre, che cerca la soluzione a casi, apparentemente impossibili.
Uno che il lunedì difende un proprio assistito a Napoli e il martedì entra in un’aula del Tribunale di Milano.
Sono un avvocato che corre, corre sempre, cercando di dare il massimo, garantendo ad ogni assistito un processo equo e giusto, uno che cerca di limitare i danni quando sa che c’è poco da fare.
Un avvocato non può che essere uno studioso, uno che divora i libri, uno pronto a ragionare, uno che cerca nelle fredde carte processuali la soluzione, anche quando non sembra esserci più la speranza.
Qualcuno mi ha detto che sono affidabile, qualcuno che sono furbo, qualcuno che sono cinico.
È vero, ogni sostantivo racconta qualcosa di me, in realtà sono uno che non si ferma mai, che fa quello che deve fino alla fine.
Se il diritto penale è la mia prima passione, ne coltivo un’altra da tempo. Sono un volontario, impegnato da sempre nell’ assistenza agli bisognosi e nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente. Questa seconda passione mi ha portato con un gruppo di amici a creare gli Specialisti del Non Profit, un team di esperti che svolge attività di informazione, formazione e assistenza nei confronti degli Enti del Terzo Settore.
Volevo presentarmi in modo classico, ma non fa parte di me.