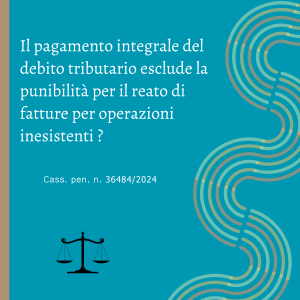Il caso scelto per la rubrica “Dialoghi Penali” consente di esaminare i limiti correlati all’esercizio della professione di fisioterapista e le eventuali responsabilità di natura penale discendenti dal superamento dei predetti, che potrebbero determinare l’integrazione del reato di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p.
Il caso…
Un fisioterapista veniva condannato per i reati ex artt. 348 e 609 co. 2 c.p. bis c.p. per aver esercitato abusivamente la professione di medico, in assenza della relativa abilitazione, eseguendo su diversi pazienti sedute fisioterapiche senza prescrizione medica, sostituendosi al sanitario nella diagnosi clinica e nell’elaborazione del programma riabilitativo.
Nel corso di alcuni trattamenti, abusando delle condizioni di inferiorità psichica delle persone offese, mediante azioni progressive ed invasive, volte a superare la loro resistenza, le avrebbe indotte a subire atti sessuali consistiti in penetrazioni della vagina o dell’ano con le dita.
La pronuncia di condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione veniva confermata dalla Corte di Appello di Cagliari, che rigettava le censure sollevate con il gravame dalla difesa dell’imputato.
L’imputato, per il tramite del difensore, ha impugnato la sentenza emessa dalla Corte di Appello sollevando con il ricorso differenti motivi di doglianza.
Ci soffermiamo esclusivamente su quelli con i quali la difesa ha sostenuto, in primis l’insussistenza del reato ex art. 348 c.p. e, poi, la configurabilità dell’errore ex art. 47 c.p.

La decisione…
La Corte nel rigettare la prima doglianza ha evidenziato che il fisioterapista ha posto in essere attività di spettanza medica, avendo formulato una diagnosi e redatto un programma di sedute sulla base dei dolori e dei fastidi riferiti dalla paziente.
“La laurea in fisioterapia non abilita ad alcuna attività di diagnosi, consentendo al fisioterapista il solo svolgimento, anche in autonomia, di attività esecutiva della prescrizione medica”.
Occorre rilevare, peraltro, da una lettura della normativa di settore, in particolare dalla Legge n. 251 del 2000 e dal Decreto Ministeriale n. 741 del 1994, che il fisioterapista ha un’autonomia esclusivamente nell’ambito del profilo e delle competenze professionali proprie della figura, sempre in rapporto con le diagnosi e prescrizioni di stretta competenza medica.
Ciò significa che l’attività fisioterapica deve necessariamente inserirsi all’interno di una preliminare individuazione del problema clinico e del tipo di risposta riabilitativa necessaria, oltre che della verifica dei risultati, nel rispetto delle prerogative che la normativa statale attribuisce al medico e al fisiatra.
Il fisioterapista può certamente procedere a una valutazione delle condizioni funzionali del paziente nell’ambito delle proprie competenze riabilitative, ma tale attività deve rimanere circoscritta agli aspetti strettamente attinenti al percorso riabilitativo già delineato dalla prescrizione medica.
Quando invece il professionista si spinge a formulare giudizi diagnostici sulle cause del malessere, a individuare patologie o alterazioni organiche, o a predisporre autonomamente programmi terapeutici, si configura l’invasione dell’ambito di competenza esclusivamente medica.
La Corte ha rigettato, altresì, la richiesta di riconoscimento dell’errore ex art. 47 c.p. sulla conoscenza della disciplina di settore che si traduce in errore di diritto di mancata conoscenza della legge extra-penale, in quanto evitabile con l’ordinaria diligenza informativa.
Nonostante il rigetto dei motivi di ricorso esaminati, la Corte ha rilevato il decorso dei termini di prescrizione del reato, dichiarando l’estinzione del predetto.
Infine, quanto al reato ex art. 609 bis c.p. la Corte ha annullato la pronuncia limitatamente ai motivi relativi al trattamento sanzionatorio e alla pena accessoria.